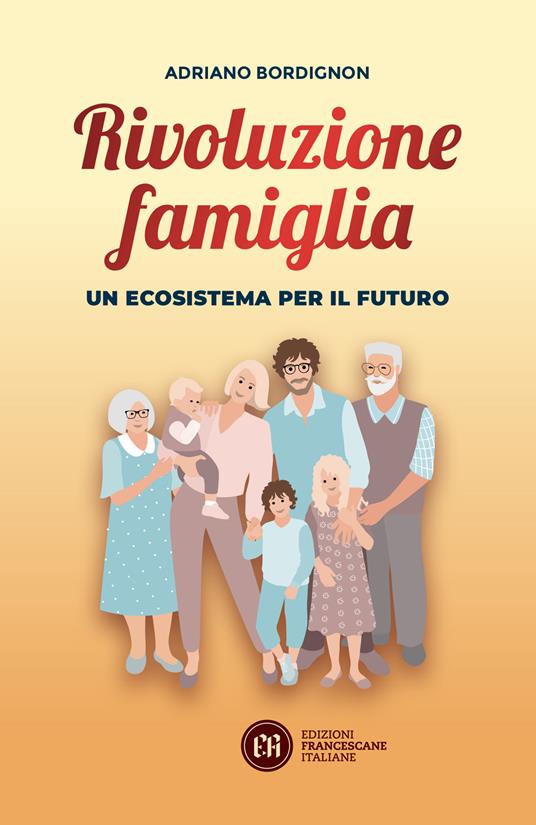L’interazione tra la vita e l’ambiente fisico crea un ecosistema. La famiglia è per antonomasia il luogo della cura, della generatività, dell’amore: ma di quali elementi ha bisogno per essere sé stessa e costituire una risorsa per il Paese e per le comunità territoriali? Attraverso le metafore del suolo, dell’acqua, della luce, del clima, dell’aria, dei nutrienti, dell’ambiente, l’autore delinea la famiglia come generatrice di capitale relazionale, produttrice di ricchezza e di servizi e promotrice di innovazione delle politiche familiari tracciando un percorso di rivalutazione della famiglia come soggetto sociale fondamento anche della collettività.
Dettagli
Autore:
Editore: Edizioni Francescane Italiane Anno edizione: 2025
In commercio dal: 27 giugno 2025
Pagine: 135 p., Brossura EAN: 9788832235845
da Avvenire AVVENIRE_04072025
Una lettura che valorizza la rete di relazioni, la partecipazione e la solidarietà mette in risalto la capacità generativa del “noi”
La famiglia? Un organismo vivente che custodisce l’ecosistema sociale
Oggi tutto è sempre più interconnesso, e la ricchezza dei legami familiari contribuisce a un sistema complesso. Al quale è legata e che contribuisce a plasmare
ADRIANO BORDIGNON
«Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile causare un tornado in Texas?». La domanda che si è posto Edward Lorenz, matematico e meteorologo statunitense, è la stessa che si sono posti – con parole forse meno poetiche – anche altri, come il fisico quantistico Wolfgang Pauli, premio Nobel per il principio di esclusione, e Carl Gustav Jung, psichiatra e psicanalista, teorico dell’inconscio collettivo e del concetto di sincronicità: esistono nessi, collegamenti, legami che ancora solo intuiamo? In fondo si tratta di cercare una risposta a un’idea semplice: tutto è interconnesso, come lo è nella nostra persona, nel nostro corpo, nella natura. Cervello, cuore, polmoni, gesti, parole, movimenti, pensieri sono tutti frutto di un processo coordinato.
La vita stessa sul pianeta Terra è stata possibile perché, intorno a quattro miliardi di anni fa, un organismo – l’alga azzurra – ha arricchito l’atmosfera di ossigeno, fino a raggiungere una concentrazione sufficiente a renderlo respirabile sotto lo strato protettivo di ozono. «Ogni cosa è collegata». Non è solo un’affermazione, ma il titolo del bellissimo libro di Gabriella Greison, in cui racconta l’amicizia e il carteggio tra Pauli e Jung. D a un punto di vista scientifico e da un punto di vista psicologico, cercavano una spiegazione a cos’è l’amore, la relazione, l’unione. Nella fisica quantistica si parla di entanglement, che vuol dire correlazione, intreccio, aggrovigliamento. Nel mondo dell’infinitamente piccolo, nella meccanica quantistica, se due sistemi entrano in contatto si scambiano informazioni ed entrano in un equilibrio armonico.
E anche se separati e a distanze siderali restano comunque collegati e si influenzano reciprocamente. Ciò che sembrava solo fisica teorica è stato dimostrato nel 2022 dai premi Nobel Alain Aspect e Anton Zeilinger. Accade anche nel mondo reale: le particelle sono tutte collegate tra loro. E questo vale sia per la vita materiale sia per quella intellettuale e spirituale. È ciò che sperimentiamo quando proviamo amore. Non vale solo per il mondo Occidentale: culture, religioni, miti più remoti ci parlano dello stesso principio. C’è qualcosa di inscritto nell’uomo e nel Creato che riconosciamo perché fa parte di noi. Siamo inseriti in un ecosistema di relazioni, affetti, interscambi che ci permettono di vivere e di essere noi stessi, ma sempre all’interno di un contesto più ampio. L o esprime anche un’espressione tipica della filosofia africana: ubuntu. Non è un concetto facilmente trasferibile in altri contesti culturali, e va compreso nella sua profondità. Il 25 gennaio 2025, in occasione del Giubileo della Comunicazione in Vaticano, la giornalista Maria Ressa, premio Nobel per la Pace 2021, ha scritto nel suo articolo La speranza viene dall’azione: « Mi piace la parola sudafricana ubuntu – “io sono perché noi siamo” –, un antidoto a tanti nostri problemi attuali. […] Il dolore di uno è il dolore di tutti. Laddove le Big Tech premiano il peggio di noi, ubuntu ci insegna che i nostri destini sono interconnessi». Ubuntu è un termine della civiltà bantu dell’Africa subsahariana: il suffisso -ntu significa “persona”, mentre ubu significa “umanità”. In Occidente potremmo interpretarlo come se la comunità venisse prima della persona, il “noi” prima dell’“io”. Ma non è così che viene inteso. Ubuntu – spiega Sabrina Conforti sul sito della Treccani – «comprende la generosità, l’umiltà, la grandezza di cuore, la bontà, la capacità di sacrificarsi per l’altro, la capacità di cooperazione e la gentilezza. Non è qualcosa che si impara a scuola, ma è un modo di vivere condiviso dalla comunità africana». La conclusione è che ubuntu non pone al centro la comunità in quanto tale ma la nostra comune umanità, il nostro essere autentico. Non l’“io” contrapposto al “noi”, ma il “noi” come espressione piena dell’“io”, in quanto appartenenti alla stessa umanità. L’io e il noi sono in relazione tra loro, non sono separati. Valorizzare il noi significa valorizzare i punti di forza di ciascuno, come in un gioco di squadra: il talento individuale è a beneficio di tutto il gruppo. Ogni persona è una tessera del mosaico. Se manca, il disegno è incompleto. Solo quando tutte le tessere sono presenti, il disegno si compie. Coltivando il “noi”, insomma, si coltiva anche l’“io”. La filosofia sottesa all’ubuntu indica che si diventa pienamente persone solo nella relazione con gli altri: con la famiglia, con i nostri vicini, fino a sentire come nostri i problemi dell’umanità. La vita, in fondo, è costitutivamente relazionale.
N ell’immaginario collettivo hollywoodiano siamo abituati a vedere rappresentati eroi solitari sullo schermo: leader carismatici, protagonisti assoluti, in cui viene esaltato il talento personale. You can make the difference, “tu puoi fare la differenza”, è lo slogan dominante del viaggio dell’eroe. Ma non è forse giunto il tempo di un eroe collettivo? Di un lavoro di squadra, di collaborazione, di aiuto reciproco, di condivisione dei percorsi? (…) Siamo, viviamo, gioiamo e soffriamo all’interno di un sistema familiare che è influenzato da tutti i tipi di esperienze – anche del passato e non conosciute – che entrano a fare parte di una coscienza collettiva che è in gran parte inconscia. Questo non significa che siamo predeterminati, né che il sistema ci influenzi per sempre, ma che acquisire consapevolezza può portarci a trasformare la realtà. La famiglia non è semplicemente la somma dei suoi componenti: è qualcosa di ulteriore, di diverso, che ci segna profondamente nel vivere il presente, nel rileggere il passato, nel progettare il futuro. Gli studiosi ci ricordano che è un soggetto sociale con diritti, doveri e responsabilità propri. Qualcosa di vivo, capace di generare vivacità e vita. La famiglia come soggetto sociale E se considerassimo la famiglia come un organismo vivente? Di cosa avrebbe bisogno per essere viva, per crescere sana in un ambiente che le permetta di essere sé stessa? Qual è l’ecosistema che consente alle famiglie di vivere, fiorire e fruttificare? Per definizione, un ecosistema è l’insieme degli organismi viventi, i componenti biotici, e delle sostanze non viventi, i componenti abiotici, che interagiscono tra loro scambiandosi materiali ed energia, all’interno di un ambiente definito – come un lago, un bosco, un prato. Animali, piante, rocce, acqua, luce, terra, temperatura, batteri, funghi: tutti elementi che, attraverso le loro relazioni, rendono possibile la vita. Gli ecosistemi si basano sull’equilibrio tra tutti questi elementi, pertanto se uno di essi venisse a mancare oppure a modificarsi, automaticamente anche l’intera stabilità dell’ecosistema verrebbe intaccata rendendo necessario cercare di ristabilire un nuovo equilibrio. Allo stesso modo, anche la famiglia – vista come un organismo vivente – è caratterizzata da una sua omeostasi: una tendenza naturale a mantenere quell’equilibrio interno, sia a livello chimico-fisico sia comportamentale, che accomuna tutti gli organismi viventi. Il sistema famiglia cerca costantemente di mantenere il suo equilibrio interno adattandosi alle pressioni esterne, ai cambiamenti sociali, attraverso la modificazione dei ruoli interni e delle pratiche quotidiane al fine di rispondere alle trasformazioni sociali.
I mmaginare la famiglia come un sistema vivo e interconnesso – sia nelle sue parti interne sia con l’ambiente circostante – ci aiuta a capire quanto sia importante creare le migliori condizioni affinché possa prosperare. Continuando il nostro ragionamento, e ricorrendo all’ausilio delle metafore, quali “componenti abiotici” sono essenziali per rendere la famiglia un’organizzazione fiorente, sana e dinamica? Suolo, aria, acqua, luce, clima, nutrienti, che effetti hanno sulla famiglia, soggetto sociale insostituibile? Ognuno di questi componenti, a modo suo, svolge un ruolo cruciale, analogo a quello che svolge nell’ambiente naturale: sostiene la vita.
Quel che è certo è che la famiglia può essere assimilata a un microsistema, a un soggetto sociale in evoluzione, che cambia nel tempo e nello spazio. Non è solo un’entità giuridica, sociale ed economica, ma rappresenta una comunità di generi e generazioni, legate da legami di sangue o di affinità, in cui si trasmettono valori, norme, tradizioni e culture. Svolge, inoltre, funzioni sociali e personali, tra cui – elenca Javier Escrivá Ivars in La famiglia come soggetto sociale – la «funzione di trasmettere la vita», la «funzione educativa e di socializzazione», la «funzione di unire in modo solidale le diverse generazioni nella trasmissione di mediazione e di attenuazione dei conflitti» e, infine, la «funzione economica e di sviluppo sociale». In sintesi, parlare della famiglia come di un organismo vivente, in senso figurato, ci consente di cogliere la sua complessità e le sue interrelazioni: essa agisce come unità sociale, ma anche come rete di relazioni dinamiche, aperta al mondo, al civismo, alla partecipazione, alle dinamiche di organizzazione, alle politiche familiari e alla sussidiarietà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA