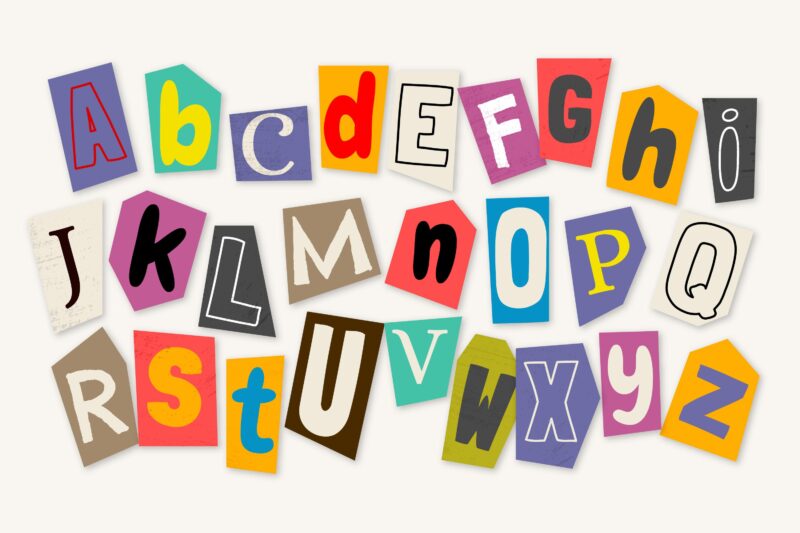Teologia / I genitori lo danno, poi risuona nella vita come una lunga litania. Ma il nome dell’origine è inarrivabile Finché il Buon pastore non lo renderà nuovo
I genitori sono genitori anche perché impongono un nome al figlio. Lo sa bene Adam Trask che, abbandonato dalla moglie subito dopo la nascita di due gemelli, fece trascorrere più di un anno prima di chiamarli Aron e Caleb. Perduta la donna con cui li aveva generati, rifiutava di riconoscerli come suoi. Così narra La valle dell’Eden di Steinbeck. I genitori scelgono il nome chissà per che motivo. Ricorda un caro, è musicale, evoca un santo o un eroe, è di buon auspicio… Serve a chiamare il piccolo e a distinguerlo dagli altri. Eppure il nome dato alla nascita non è sufficiente. Tant’è che cresce grazie a nomignoli e soprannomi, abbreviazioni, diminutivi dati in famiglia, a scuola, tra gli amici e al lavoro. Lievita perfino negli epiteti affibbiati dai nemici. Si arricchisce di sfumature inedite con gli appellativi segreti tra innamorati, nei momenti di tenerezza e di passione. Rinuncia a se stesso per trasformarsi in “papà” e “mamma” sulla bocca di un figlio. Il nome dell’origine, infatti, è inarrivabile, poiché si giunge sempre dopo di essa. Nemmeno chi le è prossimo viene chiamato per nome, ma “nonno”, “nonna”, “zio” e “zia”. Il nome è quindi una lunga litania di nomi, a cui contribuisce ogni persona incontrata, ogni tempo vissuto. È evidente nella Settologia di Jon Fosse, dove il nome del protagonista è identico a quello del suo doppio, rimbalza e si camuffa in quello dell’amata e del vicino. Forse la più antica forma di poesia fu l’inno. Nato in ambito religioso, consisteva in una litania, una lista di nomi, attributi e qualità, nell’intento di avvicinarsi al Nome sconosciuto di Dio. Era il Nome a promuovere l’avvento di tutti gli altri nomi, proprio in ragione del suo mistero. Una edizione contemporanea dell’inno antico si trova ne I trentatré nomi di Dio di Marguerite Yourcenar: «Mare al mattino… Ape… La mano che entra in contatto con le cose… Il torso umano… Il pane…». Una vita umana è il tempo necessario alla composizione dell’inno a ogni persona, della litania che intuisce il centro di gravità del suo nome proprio, senza mai raggiungerlo.È quanto canta Calaf, il protagonista della Turandot di Puccini. Tutta la città brama conoscere il suo nome. Pur di carpirlo, si ricorre a lusinghe, inganni e perfino a torture. «Ma il mio mistero è chiuso in me, / il nome mio nessun saprà! / No, no. Sulla tua bocca lo dirò, / quando la luce splenderà». Calaf è convinto di detenere il suo nome, mantenendolo segreto. In realtà, non si rende conto della serietà delle sue stesse parole: nessuno conosce il suo nome, nemmeno lui. Il suo proprio mistero è chiuso in lui, anche a lui. Conosce solo il suo nome di nascita, destinato esso pure a crescere grazie a quello attribuitogli dalla donna che lo odiava e ora è infiammata d’amore per lui. Ma quindi chi conosce il mio nome? Una pagina del Vangelo di Giovanni non ha dubbi. Lì Cristo parla di sé come il buon pastore (Giovanni 10,1-18). Cammina davanti alle pecore. Esse lo seguono, poiché ne riconoscono la voce familiare e buona. Per il gregge non teme di affrontare i lupi, anche a costo della vita. Un particolare: conducendo le pecore fuori dall’ovile «chiama ciascuna per nome». Certo, l’espressione indica un pieno coinvolgimento professionale: per lui quegli animali, a prima vista identici, non sono tutti uguali, ma riconoscibili uno ad uno. Eppure, quel dettaglio nasconde un altro aspetto, indicato da Walter Benjamin a commento del gesto di Adamo che dà il nome agli animali. Chiamando i viventi, egli non dette sfogo alla casualità stravagante e nemmeno stilò una classificazione puntigliosa. Piuttosto, grazie alla sua innocenza e alla sua giustizia, pronunciò il nome giusto e irripetibile che vibrava nel segreto di ciascun singolo animale. Dopo la caduta, Adamo perse quel potere dalla commovente bellezza. Il nome di ciascuna creatura divenne segreto e irraggiungibile, anche a se stessa. Letta in questa luce, la pagina evangelica riverbera un bagliore imprevisto. Cristo non chiama le sue pecore con il nome di nascita, ma con quello giusto, singolare, corrispondente ad un essere unico. Cristo è il pastore dei nomi. In un’altra pagina biblica, stavolta dell’Apocalisse, Gesù promette un «nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve» (Ap 2,17). Nuovo qui non indica l’opposto di vecchio, ma significa rinnovato, messo a nuovo. Il nome dato da Cristo è il medesimo che ogni creatura porta in sé da sempre: «il mio mistero» «chiuso in me». Finalmente è reso udibile e pronunciabile. Solo allora ciascun essere potrà dire realmente “Io mi chiamo…”. Per adesso dobbiamo accontentarci di litanie e inni, più o meno riusciti a seconda della giustizia che li ha ispirati.
GIOVANNI CESARE PAGAZZI Archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa